

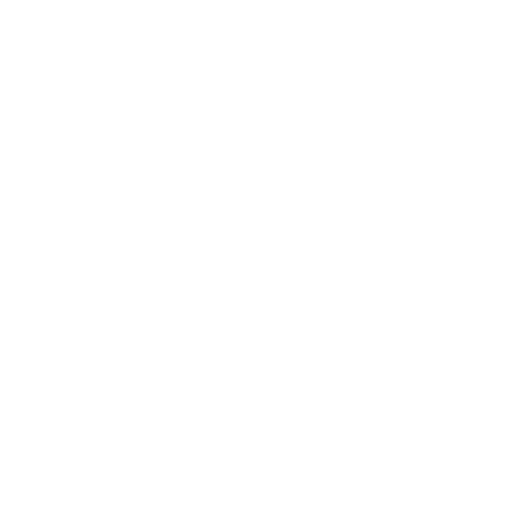
Nameless 2002, Lo Spirito del Lago, Isola Bella, Lago Maggiore, Stresa.
In quest’ultimo periodo mi è tornato in mente un lavoro, un’installazione molto particolare realizzata in un luogo altrettanto particolare. Certamente in questo caso, “ogni riferimento a fatti realmente accaduti non è per nulla casuale”, ma forse non è tutto e se questo lavoro è tornato proprio ora a farsi sentire vuol dire che è il momento per essere raccontato. L’opera è legata in modo indissolubile ad uno dei fatti più dolorosi della mia vita, come idea nasce in un cimitero e come installazione verrà esposta in un ex albergo, metafora calzante del nostro passaggio, temporaneo, da queste parti.
Agli inizi del 1992 ho perso mia madre, mio padre se n’era già andato da parecchi anni ma prima d’allora non avevo mai considerato l’importanza di un luogo dove ricordare i propri cari defunti, soprattutto il ruolo fondamentale della ritualità che si raccoglie intorno ad essi, qualsiasi forma essa assuma. Forse quando successe a mio padre ero troppo piccolo per capire, ma dovetti ricredermi. Quella tomba, con la foto di mia madre in vetroceramica, al di là del contesto in cui si trovava, un grande cimitero cittadino di burocratica disumanizzazione, fu fondamentale per ricomporre il dolore, tenerlo sotto controllo o come si direbbe in ambito sociologico, elaborare il lutto.
Durante le prime visite quella lapide, a pochi metri da quella di mia madre non l’avevo notata, i primi tempi le tombe all’interno del campo erano tutte uguali: una piccola lastra di marmo incisa, fissata su un plinto di pietra piantato nel terreno, davanti ad esso veniva steso del ghiaietto sul quale si posava una semplice croce di marmo, nient’altro. Questo in attesa che i familiari dei defunti commissionassero ai marmisti abilitati dall’ente cimiteriale quello che prosaicamente veniva definito il monumento che, a seconda del budget e del buon gusto, poteva tradursi in una lastra di pietra liscia, sagomata, concava o convessa, incisa, con inserti a mosaico, sino ad un tripudio di statue a rilevo o tutto tondo, solitamente posizionate in testata, i cui soggetti, non è difficile da immaginare, erano madonne straziate e piangenti, cristi crocifissi, corone di spine, colombe e quant’altro. Passò qualche mese, i vari “monumenti” vennero allocati, il campo prese la sua forma definitiva e allora quella tomba rimasta spoglia catturò la mia attenzione; o forse chissà, più semplicemente la notai grazie al mio incedere più leggero, quando il dolore ha finalmente avuto il tempo di sedimentarsi e ti permette di rialzare lo sguardo, d’incamminarti lungo il viale che porta al campo senza quella stretta al cuore che sembra toglierti il respiro, rendere penoso il cammino, con quello sguardo basso sulle tue scarpe che calpestano l’asfalto. L’impatto iniziale, ricordo bene, fu anche molto straniante perché lessi come data di morte 2022 e per un attimo rimasi perplesso… ma che diavolo, poi mi resi che l’anno era ovviamente lo stesso di mia madre, 1992, quei numeri indicavano la probabile età al momento del decesso, la lapide infatti riportava: “ 222 sconosciuta di sesso femminile, di anni 20/22, 21-1-1992”. Com’era possibile che una giovane donna potesse sparire così, senza nome, senza volto, senza nessuno vicino, senza alcuna identità, rimasi profondamente turbato. Mi chiesi se fosse solo un caso o se esistessero altre lapidi simili a testimonianza di un’esistenza vissuta così ai margini da ritrovarsi oltre, come se l’essere qui si fosse trasformato già in altrove, aver oltrepassato quella soglia che, malgrado la tua umanità, ti rende invisibile, immateriale, un numero, unico elemento conosciuto di qualcuno per tutti sconosciuto.
Nella successive visite a mia madre, invece d’imboccare il vialone principale che portava in fondo al cimitero dove si trovavano gli ultimi lotti inumati, iniziai a camminare nei vialetti tra i campi osservando le tombe, presto ne trovai un’altra, questa volta di un uomo, con un’epigrafe, quando è il caso di dirlo, molto più lapidaria: “maschio sconosciuto”.
Mi venne subito voglia di fare qualcosa per portare quella storia fuori da lì, non avevo ben chiaro come ma sapevo che avrei voluto trasformare quell’esperienza in un lavoro. Poi arrivarono nuove difficoltà nella mia vita, un trasferimento in una zona più lontana, relativo trasloco e anche le visite a mia madre, mio malgrado, si diradarono col tempo.
Così, come spesso accade, quell’idea che non si era subito concretizzata in qualcosa di più definito, che non era andata oltre la sua intenzione, finì per arenarsi in un angolo buio della mia mente e scomparve dal mio spazio immaginativo.
Passarono 10 anni. All’inizio del 2002 mi telefonò Giampiero Zanzi e mi chiese se volevo partecipare alla nuova edizione dello “Spirito del Lago”, una mostra che organizzava ogni anno nella stagione estiva, nei locali di un ex albergo in disuso; va detto che quell’albergo non si trovava in un posto qualsiasi bensì sull’isola Bella, la più grande delle tre isole Borromee sul Lago Maggiore. In quel luogo davvero unico Giampiero gestiva un ristorante assieme alla famiglia e sopra il ristorante si trovava, appunto, l’albergo che non veniva più utilizzato come tale perché non più adattabile alle normative vigenti. Giampiero, quindi, aveva pensato di trasformarlo in uno straordinario palcoscenico per eventi artistici. Quando mi parlò della tematica che avrebbe voluto sviluppare mi tornò in mente quell’ipotesi di lavoro ormai dimenticata da tanti anni. Come un fiume carsico che aveva fatto una lunga strada nascosto sotto terra e che ad un certo punto aveva trovato un passaggio per sbucare fuori, l’idea iniziò a sgorgare nella mia mente in modo chiaro, cristallino. Ora sapevo perfettamente cos’avrei fatto, sarei tornato da quella sfortunata, giovane donna, avrei fotografato la sua lapide, poi avrei cercato e fotografato le altre mancanti: nove, una per ogni anno, dal 1992 al 2002. Naturalmente se non le avessi trovate, niente lavoro. Sapevo anche dove avrei fatto l’installazione, in una delle camere più piccole ma anche più belle dell’ex albergo: due pareti spoglie ai lati e quella di fronte all’entrata quasi interamente occupata da due grandi porte vetrate aperte sul lago. Era una stanza raccolta, intima e per la sua vista di grande bellezza, forse quando l’albergo era ancora in funzione quella preferita dai giovani innamorati, quell’estate del 2002 sarebbe stata per loro, i senza nome. Le prime cinque immagini in sequenza sul muro a sinistra, le altre su quello a destra, di fronte il lago, era perfetto così. In seguito pensai che non avrei voluto appendere le stampe alla parete, scartai anche l’idea di poggiarle a terra, allora realizzai dei supporti da fissare al muro sui quali montare le stampe in modo che rimanessero appese ma distanti dalla parete. Paradossalmente i supporti si notano molto di più nelle fotografie di quanto si percepissero dal vivo, infatti essendo piccola la stanza era difficile da inquadrare anche utilizzando obiettivi grandangolari, l’unico modo era quello di porre la fotocamera molto radente alle pareti per ottimizzare lo spazio dell’inquadratura, facendo di conseguenza apparire i supporti sui quali le stampe erano fissate. Dal vivo invece, una volta entrati al centro della stanza, si aveva la sensazione che le immagini fossero sospese nel vuoto contribuendo a creare un’atmosfera rarefatta, come se il tempo fosse anch’esso sospeso, attraversato dal fluire continuo dell’acqua di fronte a se. Forse è proprio quest’elemento, invece del riferimento più ovvio, che mi ha fatto tornare in mente quest’ installazione.
Nelle stanze dell’ex albergo non esisteva più alcuna illuminazione, l’opera avrebbe vissuto seguendo il ciclo naturale della luce che entrava dalle finestre, quando calava il buio
l’unica luce era quella di un grande cero, fuori scala, alto due metri, più che un rimando all’oggetto candela, una presenza fisica, un elemento architettonico posizionato tra le due porte finestre.
Il 2002 era il decennale della scomparsa di mia madre, sono convinto che avrebbe apprezzato quel lavoro, lei mi aveva educato a stare dalla parte degli ultimi sin da bambino quando giocavo a indiani e cowboy, mi aveva insegnato che la storia non era quella raccontata dai film, che gli indiani non erano i cattivi.
Non sono portato per le celebrazioni, non sono portato per un sacco di cose, in fondo so fare solo questo, pensare a cose come questa…
Quella fu la mia dedica segreta.
Francesco Garbelli, 2020, Milano








